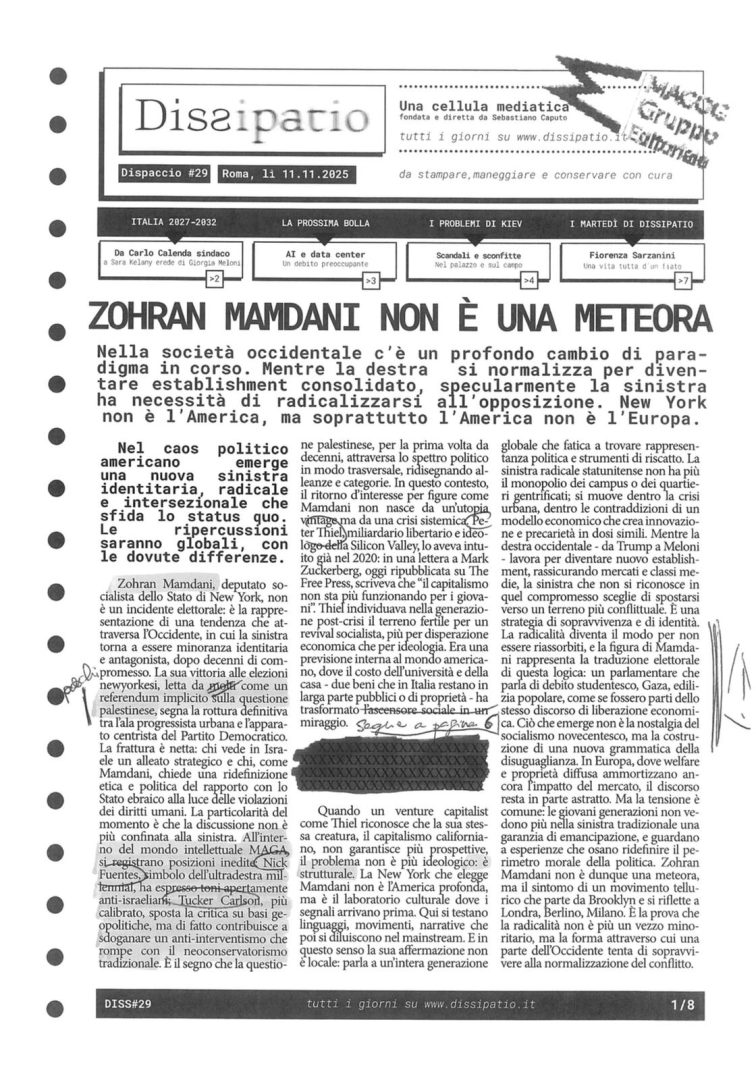In questi ultimi anni la situazione geopolitica libica è cambiata drasticamente, la quale oggi rimane quasi “impantanata” in una sorta di gioco di logoramento fra tutte le parti che operano e hanno interessi a rimanerci dentro – e la cui situazione è molto più instabile e complicata di quanto ci si possa aspettare. Ciò, oltretutto, non è solo un semplice stallo in cui tutti sono pronti a collaborare con tutti e, al contempo, a portare avanti piani e politiche per soppiantare i propri partner appena si scorge la possibilità di avvantaggiarsi, senza però far crollare l’intero equilibrio esistente; si tratta anche di una questione che esula dal solo significato e peso politico e geopolitico, addentrandosi così in trame molto più fitte e legate a un cambiamento globale – e umano – in atto.
Principalmente questa situazione, pur nella sua scarsa rilevanza giornalistica, è una delle tante rappresentazioni che possono restituire l’immagine dell’evoluzione attuale e costante che si sta delineando nell’essenza stessa della politica, degli stati, delle società e degli uomini; un’evoluzione, però, che si sta pian piano liberando da tutti e quattro i corpi per farsi essa stessa loro dominatrice. Tutto ciò non riguarda tanto un cambiamento di tipo ideologico, dottrinale o geopolitico, ma ha a che fare col modo stesso in cui i tre componenti (uomini, società e stati) interpretano la realtà stessa, sia quella interiore – nella loro soggettività, comunità e astrazione – e sia esteriore – il loro rapportarsi e interagire con altri soggetti, oggetti e flussi di dati. Insomma, il cambiamento qui è, in primis, ontologico e gnoseologico; il concetto stesso di “evoluzione” si defila dalla conoscenza e dal controllo umano per diventare cosa a sé stante. E con il cambiamento di quei punti di riferimento con cui l’uomo si è sempre mosso nella vita, nel rischio e nella necessità politica (come il definirsi dell’identità; la coscienza, anche solo simbolica, di certe Leggi e modi di riconoscere l’altro; una struttura definita e concreta della conoscenza della realtà; etc.), ebbene, anche il suo stesso modo di agire e di pensare (esistenzialmente e politicamente) si fa sempre più fluido.
Non è più il fatto a contare, né ciò che quel fatto rappresenta nelle idee e aspirazioni degli uomini; l’unica cosa che conta è agire e pensare per evitare di uscire fuori dal sistema e venir così liquidati dalla stessa possibilità di poter essere nel flusso. Le idee ormai si stagnano, le geostrategie si fanno sempre più simboliche e caute, il conoscere e rapportarsi degli uomini con sé stessi e le collettività diventano puro gioco di immagine e speculazione. In particolare, al di là delle contingenze geopolitiche fra gli stati e della persistente domanda che ogni nazione si pone nella Storia (ovvero: qual è la mia Identità?), la Libia potrebbe mostrare come certe logiche legate alla supremazia, alle necessità degli stati e del loro modo di interagire con i dati, le altre entità statali (altre Identità) e il linguaggio stesso della politica (e non solo) stiano cambiando in modo estremamente rapido, senza accennare alcun freno. Senza lasciare nemmeno la possibilità di rivedere e cambiare i ritmi e l’essenza di questo cambiamento e né, così, di poter far tornare il primato della gestione e del significato della politica agli stati, che gli sta sempre più venendo sottratto dalla pura e potente mole di input/output che gli stessi Leviatani sono costretti a fornire alla crescente circolazione di informazioni e feedback.
L’attuale teatro libico è caratterizzato da una complicatezza di rapporti e fili rossi i quali, aggrovigliatosi tutti fra di loro, mettono in luce una situazione in cui tutte le potenze in campo si muovono, diplomaticamente e militarmente, senza però scomporre radicalmente l’assetto che, nel tempo, si è andato a creare in Tripolitania e Cirenaica. E tanto le forze di Tripoli, quanto quelle di Bengasi e Tobruk, rimangono più delle pedine in cerca di autorità, stabilità e profitto da quelle potenze straniere che le assistono e sfruttano o per costruire reti di aiuti e investimenti atti al continuo uso ed estrazione delle loro risorse, come gas e petrolio, e anche per salvaguardare i propri interessi interni legati al problema dell’immigrazione (Italia e Occidente), o per usarli come base strategica di approvvigionamento per le operazioni diplomatiche in Occidente e militari in Africa (Russia), oppure per espandere la propria influenza nel Mediterraneo, in particolare quello orientale e del sud e acquisire nuove “armi sporche” (leggasi: immigrati) per mantenere il proprio potere e poter patteggiare meglio con i vari competitor nell’area (Turchia).
La Libia, oltretutto, non è divisa solo fra il governo di Tripoli, ovvero il Governo di Unità Nazionale presieduto da Abdul Hamid Dbeibeh, riconosciuto e sostenuto da Italia, Turchia, altre nazioni occidentali e l’ONU, e fra quello di Benghasi/Tobruk, guidato de iure dal presidente Osama Hammad ma de facto controllato dal generale Khalifa Haftar, e supportato dalla Russia, dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti. Al di sotto dei governi e delle politiche ufficiali di Tripolitania e Cirenaica, operano molti altri gruppi locali e non, militari, tribali e/o economici i quali, pur facendo parte, spesso, delle medesime alleanze, hanno a cuore anzitutto i propri interessi – e la volontà di perseguirli in ogni modo senza che le cose cambino completamente. Tripoli, forse, fra le due parti, è quella più svantaggiata: pur controllando alcuni degli asset economico-politici e strategici più importanti della Libia (come la Banca Centrale della Libia; la National Oil Corporation, che riceve persino i proventi dalle aree controllate da Haftar; vari hub nel sud e vasti giacimenti di gas), ha comunque in sé e accanto a sé la maggior quantità di forze militari e politiche, le quali sono una minaccia (più o meno diretta) agli interessi stessi di Tripoli. Questo assortimento di fazioni riguarda, in particolare, le milizie filo-statali presenti a Tripoli, Zawiya, Sabrata e Gharyan (le quali, recentemente, si sono scontrate per ottenere il controllo di aree e incarichi politicamente rilevanti nel governo della regione); a Zintan, Misurata, Sabha (dove operano milizie tuareg filo-Tripoli) e Kufra (dove le tribù locali collaborano con il governo). Oltre ai gruppi e alle unità militare teoricamente fedeli al governo di Tripoli, vi sono poi altri gruppi come le milizie tribali di tuareg, toubou e gruppi arabi, i quali creano scompiglio nella regione sia per la loro volontà di ottenere autonomia e potere e sia perché molti loro gruppi sono affiliati al traffico di esseri umani, di carburante e droga. Vi sono poi gruppi che operano in tutte e due le regioni, come la Libya Shield Force di ispirazione islamista; e altri ancora che provengono da territori stranieri, come i miliziani siriani dell’Esercito Nazionale Siriano, schierati direttamente nell’area di Tripoli. Infine, la Turchia, che oltre ad avere una presenza piuttosto stabile sia grazie ai propri consiglieri militari, addestratori, mercenari (non solo siriani, ma anche della compagnia privata Sadat) e armamenti, ha anche de facto il controllo di alcuni punti militarmente strategici nella Libia occidentale, come la base marittima di Al Khoms o quella area di Al-Watiya.
Oltre a tutti questi attori, vi è poi la più flebile presenza italiana, la quale ha sia un ristretto contingente militare e delle missioni di cooperazione e addestramento attive (come le missioni MIASIT e “Mare Sicuro”), e sia anche una piuttosto radicata presenza economica (anche se sempre più sottratta dalla Turchia) grazie all’ENI e ad altre aziende legate agli idrocarburi, all’edilizia e alle energie rinnovabili. Roma, però, non agisce unicamente in Tripolitania, ma cerca anche di mantenere il proprio controllo sulla Libia, che sembra quasi destinato ad essere relegato a secondo piano, interagendo anche con la parte orientale di quella, ma senza grandi esiti: l’ultimo evento della serie di forum economici italo-libici, avvenuto fra il 24 e il 26 giugno di quest’anno a Bengasi, non sembra aver portato grandi vantaggi alla Penisola, la quale, oltretutto, si è persino vista, l’8 di questo mese, il proprio ministro degli interni (insieme a quelli di Malta e Grecia e al commissario UE per la migrazione) venir respinto all’aeroporto di Bengasi e considerata come “persona non gradita”. Atto, questo, portato avanti, molto probabilmente, per ottenere una maggior legittimazione, per Bengasi e Tobruk, di stato sovrano e riconosciuto, pur essendo quest’ultimo ancora in una fase molto delicata di stabilizzazione. Se nell’ovest la situazione militare e politica è piuttosto complessa e quasi disorientante, anche nell’est la cosa non è da meno: Haftar presenta il suo Esercito Nazionale Libico come una forza militare omogenea e organizzata, ma nei fatti essa è composta da milizie semi-indipendenti, talvolta tribali, persino da forze ex gheddafine, oltre che da mercenari sudanesi e ciadiani e persino dalla compagnia e milizia privata della Petroleum Facilities Guard. Oltre a ciò, bisogna anche tener conto di tutte le forze politiche (e molto spesso militarizzate) divergenti fra di loro, ma che operano all’interno dello stesso LNA, come i già citati gruppi gheddafiani, oppure quelli nasseristi o, persino, quelli salafiti; da ciò è comprensibile l’eterogeneo supporto che Haftar riceve dai paesi esteri: non solo Russia, ma anche Egitto, Emirati, Arabia Saudita, o anche da organizzazioni e gruppi paramilitari come Hezbollah, o le Rapid Support Forces sudanesi.
Anche se con molti alleati, Haftar deve affrontare anche molti e agguerriti nemici: in primis il governo di Tripoli e i suoi alleati (anche se, al momento, è in corso un cessate il fuoco non troppo rispettato), e infine le organizzazioni di stampo islamista quali: ciò che rimane del Consiglio della Shura dei Rivoluzionari di Bengasi, la Fratellanza Musulmana e lo Stato Islamico. La situazione politica e militare delle due Province è, dunque, estremamente delicata, pronta a traballare o persino a crollare in poco tempo; eppure, anche fra i grandi stati stranieri che operano in Libia, la situazione non è molto diversa. L’Italia, pur mantenendo le sue mire strategiche e politiche in Libia, sia per la questione dei giacimenti e delle infrastrutture legate all’estrazione e al trasporto di gas e petrolio (come il gasdotto Greenstream, che collega i giacimenti di Wafa alla Sicilia) e sia per mantenere un certo controllo delle rotte e del traffico di migranti provenienti, in particolar modo, dalla regione del Sahel e dell’Africa occidentale, ebbene, Roma sta pian piano venendo scalzata dal suo ruolo di egemone e principale intermediario di Tripoli, e anche nell’est non sta riuscendo ad inserirsi come vorrebbe per poter rafforzare questo suo ruolo di garante di pace e stabilità e di portatrice di investimenti (e dunque di guadagno e influenza per la Penisola). E al contempo, viene sempre più messa in secondo piano e quasi scacciata dal neo-ottomanismo della Turchia, la quale non solo rafforza la sua presenza in Tripolitania con le armi, ma lo fa anche con solidi piani di investimenti infrastrutturali, energetici e, ovviamente, militari, senza parlare poi degli accordi presi col governo di Tripoli: dai contratti per gli appalti per la ricostruzione del paese, come per la costruzione di centrali elettriche e di energie rinnovabili, aeroporti, centri commerciali e altre strutture strategiche; alle forniture e addestramento delle forze militari e di polizia; fino poi agli accordi sulla delimitazione delle acque territoriali libiche e a un vertiginoso aumento dell’export Turchia-Libia di circa il 65%, ebbene, Ankara non rivendica solo una forte stabilità e libertà di manovra in Libia, ma anche lì dove vorrebbe davvero mettere le mani: il Mediterraneo del sud e orientale.
Ma tutte queste manovre, oltre ad essere, potenzialmente, compromesse dalla non facile situazione interna libica e dalla (seppur non così forte) presenza italiana e occidentale, devono rispondere e adattarsi alle mosse della terza potenza egemone nella regione: la Russia. Quest’ultima, presente sin dal 2018 tramite il Gruppo Wagner, trasformatosi poi in Africa Corps e assorbito nel ministero della difesa russo dopo la morte di Prigozhin, è un caposaldo fondamentale per la resistenza di Haftar verso il GUN e la Turchia: proprio come questa fornisce armamenti, addestramento e supporto d’intelligence alle unità tripolitane, anche i russi, con le proprie forze mercenarie, svolgono gli stessi compiti con le truppe dell’LNA. D’altronde, Haftar non potrebbe fare altrimenti, vista la radicata presenza russa sulle sue terre: con varie basi militari che si occupano del supporto e della logistica non solo in Libia, ma anche nelle altre operazioni nell’Africa profonda, come la base aerea di Al-Jufra, o quelle di Khadim, Al-Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra, AL-Qurdabiya; o una possibile base navale a Tobruk, ebbene, i russi esercitano un controllo forte ed esteso su tutta la Cirenaica e parte del Fezzan orientale, i cui principali interessi si rivolgono alle risorse della zona: in primis il petrolio, che viene usato per finanziare sia le operazioni in Africa e sia come merce per contrattare con l’Occidente.
Insomma, lo scenario che si presenta è quello di un grande scacchiere in cui, oltre all’instabilità perenne (e per il momento assopita), alla settarietà politica e militare e all’incertezza di quale possa essere il futuro della Libia, ebbene solo una cosa è certa: tutte le nazioni che hanno interesse a ricostruire la Libia e ad aiutare una delle due parti (e talvolta il loro riappacificarsi) lo fanno, in fin dei conti, solo per mantenerla sotto scacco e usarla come mezzo di approvvigionamento, di contrattualità e di lotta. D’altronde, questa è la natura degli stati e della politica, e proprio per via di questa loro natura, e per via anche di un altro elemento fondamentale che permea il contratto sociale fra gli uomini, ovvero il mito, ogni stato vede e agisce solo in funzione dei suoi interessi (naturali e ideali) nello scenario in cui si ritrova e che vorrebbe creare sia per assicurarsi la propria sicurezza e prosperità e sia per adempiere a quel mito fondativo che nasce e alimenta i suoi interessi. Ma vi è una differenza fondamentale fra i meta-imperi odierni e quelli antichi: i primi, a differenza dei secondi, non hanno una reale visione universalista di sé e del mondo stesso, poiché una potenza che sia veramente tale ha bene in mente che non è il modello che va esportato, ma è un nuovo destino unificatore che va fondato. E le potenze moderne, al pari di enormi tribù più che imperi, vogliono assicurarsi solo la propria sopravvivenza e forza in vista sia di questa logica e sia dell’attuale assetto geopolitico, sempre più spostato verso la multidimensionalità, lo scontro fra le parti e la meccanizzazione.
Dunque, la Libia, pur non essendo così nominata e discussa dall’informazione, rimane comunque un punto di estrema importanza per quella che si potrebbe definire come la seconda delle trasposizioni della guerra civile spagnola: la prima che si combatte soprattutto con le armi e il sangue in Ucraina, e questa seconda che si combatte economicamente e con astuzia proprio sotto casa nostra. Così proprio come accadde durante la guerra civile di Spagna, nel primo caso osserviamo come una parte del mondo (quella euro-occidentale) stia portando avanti non tanto una guerra, quanto un’agenda volta ad assicurarsi influenza e risorse nell’est (come, per esempio, con l’accordo sui minerali siglato fra Trump e Zelensky); mentre l’altra (quella asiatico-europea) cerca di ritagliarsi (in particolare Cina e India) una maggior dipendenza da parte russa sia per le forniture di materie prime e lavorate e sia per fungere da intermediari fra l’Euro-Occidente e Mosca. Nel secondo caso, quello Libico, vi è persino di più. A prevalere è un tipo di logica quasi metternichiana: pur volendo conseguire il dominio completo del medesimo territorio, le potenze che vi operano sanno che, oltre ad esser strettamente legate l’una con le altre, se una di queste dovesse cercare di spezzare nettamente questi complessi legami per prendersi tutto sarebbe osteggiata da tutti gli altri; inoltre, persino le popolazioni e le milizie locali divengono tanto comparse quanto merce di scambio e di guerriglia fra le parti.
Una volta fatta quantomeno un’incisione sul velo di Maya, tutte le sfumature degli assetti libici in particolare e geopolitico in generale odierni, nonché i loro significati, si fanno ora più chiari. Si può affermare che, al di là di una situazione di rinnovato stallo superficiale e di ebollizione interna della Libia, tutto ciò potrebbe mostrare come il modo di interagire e di competere fra gli stati si stia sempre più adattando alla potenza dei “feedback tecnici” di una realtà che è sempre più sommersa da dati, paranoie, velocità delle azioni/reazioni e, dunque, da una rete sempre più fitta e sfumata di strati di realtà, di convinzioni e persino di convenzioni. E, al contempo e paradossalmente, che si stia riavvicinando a una gestione dei conflitti e degli affari similmente a come accadeva nei secoli XVIII e XIX. Per sintetizzare ciò: la realtà sta divenendo un vero e proprio big data center, in cui i dati non vengono più semplicemente stoccati, analizzati e riformulati ogni volta, bensì divengono autogeneranti grazie all’enorme mole di informazioni (“grezze” e “raffinate”) accumulate ed elaborate nel corso della Storia, e di cui i principali analisti e utilizzatori (uomini, società e stati) non riescono più a tenere né il passo né ad organizzare efficacemente. Analizzando il tutto più nel dettaglio, si è affermato che, in particolare nel mondo Euro-Occidentale e in quello Asiatico-Europeo, le dinamiche del potere (in campo internazionale e interno agli stati) sono mosse da un nuovo modo di concepire lo stato, il suo essere e il modo in cui deve agire, che qui ora si potrebbe chiamare come “marketing di stato”. Nome e definizione che nascono da quelle tendenze che, già dalla metà del secolo scorso, hanno iniziato a rimodellare l’assetto esistenziale e operativo degli stati e delle società, per poi giungere ai nostri giorni.
In primis vi è l’inizio della decostruzione e, al contempo, di un sovraccarico di una delle principali fonti-mezzi che l’uomo possiede per definire sé stesso e il mondo che lo circonda – e che usa per imporsi: il linguaggio. Quest’ultimo, ovviamente, non è mai stata una componente dell’essere umano stabile, ben definita e organizzata in modo rigido; anzi, probabilmente, rientra in quelle componenti di cui meno abbiamo controllo e che più impattano sulla nostra esistenza. Dunque, la questione del linguaggio non fa riferimento tanto al cambiamento di qualche termine o al ritorno di vecchi vocaboli. Ciò che veramente ha iniziato a cambiare è il fatto che è il linguaggio stesso ora a reinventarsi, a dettare i significati, i termini e le informazioni alla realtà e, in questo caso, anche alla politica. Un tipo di linguaggio cibernetico. Su questo discorso e quello in merito alla crescente difficoltà umana di estrapolare, analizzare, organizzare e interpretare i dati, si può anche accennare al concetto di “ipernormalizzazione”, coniato dall’antropologo Alexei Yurchak e ripreso da un documentario della BBC del 2016 diretto da Adam Curtis. Così come i due affermavano, nelle loro opere, che l’ipernormalizzazione, fenomeno in cui una realtà fittizia e semplificata viene posta al di sopra della “realtà reale” sia come processo di “rassicurazione” e sia per una mancanza di prospettive alternative alla stessa realtà, è un fenomeno che ha colpito e colpisce gli stati e i “grandi sistemi” ad essi collegati, ebbene si può affermare che, per via di questo processo in atto e in espansione, si stia facendo sempre più strada un tipo di pensiero “tecnico”.
Questo è un modo di pensare e di identificarsi degli stati, delle società e degli individui che porta sempre più a vedere il mondo come a un circuito chiuso, dove sono solo i feedback dello stesso (positivi e/o negativi) a formare la realtà presente e futura. Si tratta di una serie di iperstizioni bloccate in un unico sistema (che le modella). E così il concetto di “marketing di stato” e il come si relazioni ai vecchi sistemi sette/ottocenteschi, pone a suo proprio fondamento e pilastro che sorregge questa intera costruzione questa logica pianificatrice del “pensiero tecnico”, che non riguarda il mero pragmatismo, bensì proprio quella semplificazione e astrazione dell’enorme mole di dati a cui ogni stato deve far fronte. Pertanto, la logica che si sta stagliando ed evolvendo non è quella di un sistema decisionale e di un pensiero razionali e visionari, bensì di un sistema che, giunto ad un grado troppo elevato di gestione delle informazioni e delle azioni da esse derivate, ha iniziato a chiudere sempre di più qualsiasi faglia che possa portare all’implosione della struttura e, così, anche a costringere i suoi stessi componenti (ribadiamo: uomini, società e stati) a reagire unicamente a un continuo “brainstorming”. E tutto ciò porta proprio al già citato ritrovamento del modus operandi sette/ottocentesco: non sopraffare, non essere sopraffatti; ma in questo caso, perché facendolo si rischierebbe non l’instabilità, ma il collasso della rete stessa.
Non si può più osservare né la situazione particolare libica né quella più generale del mondo come a un relazionarsi e agire di stati senzienti e con un’Identità, bensì come a un continuo scambio di reazioni e di input fra diversi oggetti, strutturalmente dipendenti l’uno dall’altro, che operano e fanno funzionare la medesima macchina che detta ritmi e prassi a tutti i suoi componenti. E così, tutti sono clienti di tutti; tutti si muovono sugli stessi, fragili equilibri; tutti sono ingranaggi assuefatti dello stesso sistema.