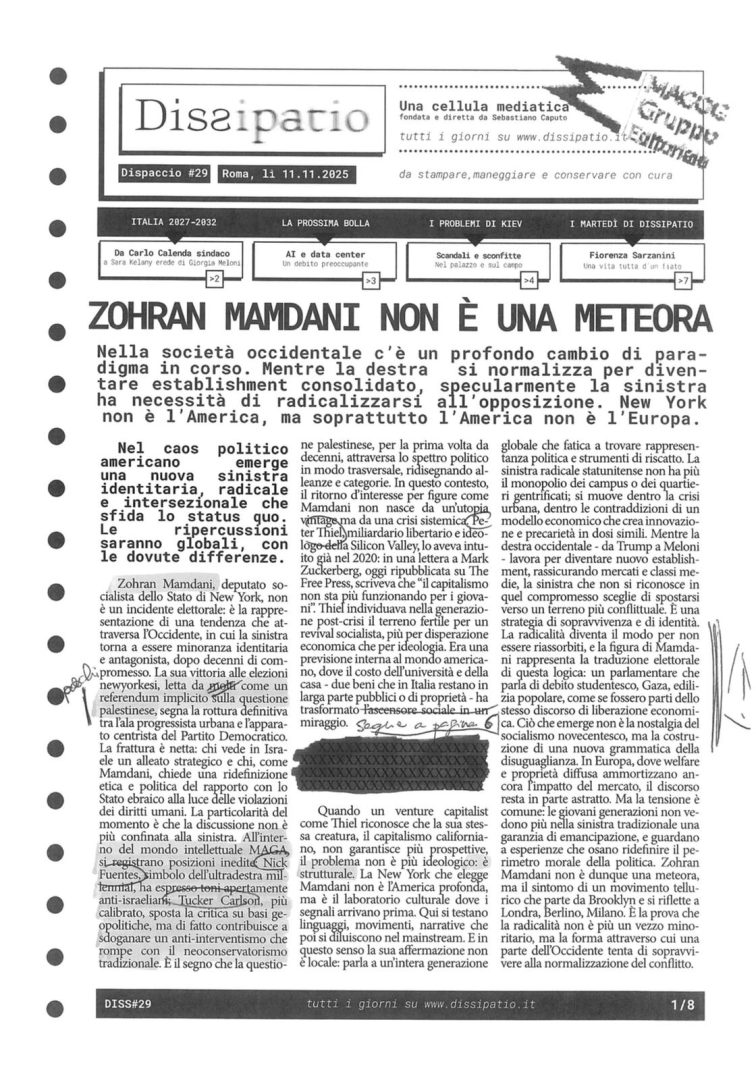Ogni volta che interpreta, l’individuo si rivolge sempre a un contenuto, che si presume stia di fronte all’interprete come qualcosa non solo di leggibile ma anche di alterabile. Secondo Paul Ricoeur, ogni interpretazione genera una spirale che non può mai chiudersi su sé stessa, dando luogo a un processo potenzialmente infinito. Ma se ogni contenuto è, a sua volta, frutto dell’interpretazione, si apre una regressione all’infinito che può trovare un limite solo nel riconoscimento che esiste un interpretato non interpretabile. È necessario che vi sia un interpretato originario, che non sia esso stesso una nuova interpretazione, ma che costituisca il fondamento non arbitrario dell’apparire. Qualcosa che non possa essere prodotto o generato all’interno dell’evoluzione storica. Un contenuto che non sia frutto dell’esperienza, poiché ogni esperienza si inserisce entro un orizzonte interpretativo.
L’interpretazione cerca, nel suo gesto, di afferrare un senso, ma il gesto stesso della ricerca implica che il senso non sia nella disponibilità dell’interprete. Ciò verso cui tende l’interpretazione non può dunque coincidere con ciò che essa stessa istituisce. Deve esserci un dato originario, un contenuto che si sottrae alla possibilità di essere ulteriormente fondato. Un senso che non sia attribuito, ma necessario. E tuttavia, anche questa necessità, se intesa come categoria, rischia di diventare a sua volta oggetto di interpretazione, e quindi di essere strappata al suo fondamento, nel tentativo dell’uomo di comprenderla. È necessario, allora, che l’interpretato originario non sia semplicemente un’idea tra le altre, ma ciò senza cui niente potrebbe apparire, ciò che Severino individua nel “destino della necessità”. Per poter interpretare il destino, cioè cogliere il senso della struttura necessaria dell’apparire del mondo, all’individuo immerso nel nichilismo non resta che pensare il destino come oggetto, cioè come qualcosa che ancora una volta si dà al potere dell’uomo. È qui che si annida la violenza originaria della volontà interpretante: essa si radica nell’impossibilità dell’uomo di cogliere integralmente il destino senza separarsene.
La volontà interpretante non si limita a cogliere il significato dell’essere, ma impone un senso che risponde all’intenzione di dominarlo e trasformarlo. La volontà di interpretare il mondo, credendo che l’interpretazione possa fondarlo, è la radice ultima della violenza. Ogni guerra, ogni conquista, ogni progetto tecnico-politico si fondano sulla convinzione della disponibilità degli enti. Il tentativo di creare città intelligenti o orchestrare conflitti tecnologicamente avanzati riflette la volontà di plasmare il materiale, che si crede a disposizione dell’uomo, per imporre la propria potenza. Ma staccandosi dalla retorica performativa moderna, anche la più semplice pretesa di trasformare il mondo, come l’opera innocua di un artigiano, è già un conflitto latente, perché si fonda sull’idea che ciò che è possa essere distrutto e ricostruito. Persino l’atto più innocente dell’attribuire un senso è l’espressione della volontà di dominio. E’ nel gesto stesso del separare, da parte della volontà, cioè nel voler isolare ciascun ente dagli altri onde poterlo dominare, che si consuma la follia dell’Occidente. Dividi et impera.
Ogni decisione è espressione della volontà interpretante di disporre degli enti, coincidente con la volontà di separare gli enti dagli altri e quindi dal loro essere eterni, per ridurli a strumenti dell’opera dell’uomo. Laddove la volontà interpretante crede di poter cogliere e determinare ciò che è, senza riconoscerne l’eternità, si inaugura la volontà di scissione. Ogni conflitto è un atto interpretante: pretende di decidere chi debba essere e chi non debba più essere. Ogni decisione è una negazione dell’essere. In tale senso, la volontà interpretante non è solo uno strumento teorico, ma la radice metafisica della violenza. Il gesto che intende separare l’ente dal suo essere eterno è già, in sé, un gesto violento, perché si fonda sulla convinzione che l’essere possa non essere. Se le origini dei conflitti appaiono nelle divergenze politiche, economiche o ideologiche, l’inconscio dei conflitti è la struttura dell’interpretare, che è già volontà di separare e di appropriarsi, ovvero di gettare nell’interpretabilità ciò che è invece assolutamente sottratto all’arbitrio dell’uomo.
I conflitti che attraversano il presente, dalle guerre più devastanti fino alle più sottili tensioni nei rapporti umani quotidiani, sono manifestazioni della medesima matrice: l’atto attraverso cui l’uomo pretende di interpretare il mondo. L’intero orizzonte dell’Occidente è plasmato dalla follia di questa pretesa: l’ente viene separato dal destino, scisso dalla propria eternità, e reso oggetto disponibile nei “progetti”, secondo un’ottica manipolatoria ad uso e consumo. Nell’illusione dell’uomo che appartiene alla Terra isolata dal destino, l’ente viene reso suddito nel regno della disponibilità tecnica. Tuttavia se si considera l’ente come eterno, ogni tentativo di manipolarlo è vano. Pur essendo vano, quel tentativo di negazione della verità del destino, è anch’esso parte dell’eternità. Nonostante sia atto violento, ed al pari di qualsiasi atto violento, il gesto che l’uomo crede essere creazione e distruzione, altro non è che illusione.
Persino parlare della necessità del destino, in quanto azione che appartiene al linguaggio, è interpretazione del destino. Come afferma Severino “anche la volontà di testimoniare il destino è il loro separarli da tale relazione; e rimane un interpretare separante malgrado la sua intenzione di indicare il destino. Nemmeno il linguaggio che testimonia il destino può dunque contenere il destino (altrimenti la verità sarebbe il contenuto ultimo della non verità).”. Se ogni opera dell’Occidente è malata “Decidere di uscire dalla storia dell’Occidente è come voler saltare al di là della propria ombra.”, proprio perché ogni decisione implica la salvezza per mezzo della volontà.
Al pari di qualsiasi interpretazione, anche la testimonianza del destino non sfugge alla sorte di qualsiasi espressione della volontà, non ottenendo mai ciò che desidera. Ciononostante, mentre il mare delle altre interpretazioni si mostra come il luogo in cui il senso viene continuamente deviato, la testimonianza del destino è l’unica interpretazione che riconosce di non poter fondare da sé il proprio senso. Il pensiero che dimostra e vede la necessità dell’essere, e quindi la sua eternità, resta l’unico gesto non violento perché non vuole, non modifica e non dispone ma, seppur interpretando, scorge l’eternità. Se, dunque, ogni atto che pretende di agire nel mondo come se il mondo fosse disponibile è follia, l’unico gesto non folle è la testimonianza del destino perché nonostante resti una forma di violenza, si disinnesca nella consapevolezza.
I conflitti del nostro tempo sono l’effetto visibile di una struttura ontologica invisibile, ovvero la convinzione che l’ente possa essere nulla, e in questa illusione si consuma la radice della violenza. Contro tale illusione, la necessità del destino mostra la follia dell’interpretazione che crede di potersi sostituire alla verità. Sotto la luce del destino ogni agire, dal più alto al più insignificante, può smettere di essere espressione di dominio e cominciare a essere gesto di verità.
In chi pianifica un conflitto, può risuonare l’eco di una colpa non nominata, come se l’atto stesso della distruzione contenesse una memoria originaria dell’indisponibilità dell’essere. Nel medico che salva, come in colui che assiste al morire, potrebbe risuonare l’eco dell’eternità dell’ente vivente, che nessun sapere e nessun potere riescono a rendere del tutto disponibile. L’impotenza ultima che ogni medicina incontra, non è solo biologica: è ontologica. Essa rimanda al limite invalicabile della tecnica, alla verità che la vita è e non può diventare nulla, anche se ogni gesto della medicina, nella storia dell’Occidente, sembra agire sulla premessa opposta. In questo senso, anche nell’atto terapeutico, massima espressione della volontà di conservare, può annidarsi il trasalimento, come il segno non detto che la cura autentica non consiste nel dominare l’essere, ma nel comprendere la propria impossibilità a disporne. E, lo si ribadisce, non si tratta di coscienza morale, ma di incrinatura ontologica che svela la soglia oltre la quale ogni volontà interpretante si frantuma.
La volontà interpretante cerca, invano, di afferrare un fondamento che, tuttavia, non è disponibile. Il contenuto ultimo dell’interpretazione non può essere contenuto nel linguaggio proprio perché è ciò che consente al linguaggio stesso di articolarsi. Se fuggire dall’atto di interpretare è impossibile nella terra isolata dal destino, nel momento in cui l’uomo riconosce che qualsiasi interpretazione, nel suo proseguire infinito, non può fondare sé stessa né giustificare il proprio contenuto, ma richiama, necessariamente, un interpretato che non può essere a sua volta interpretazione, germoglia la testimonianza del destino.