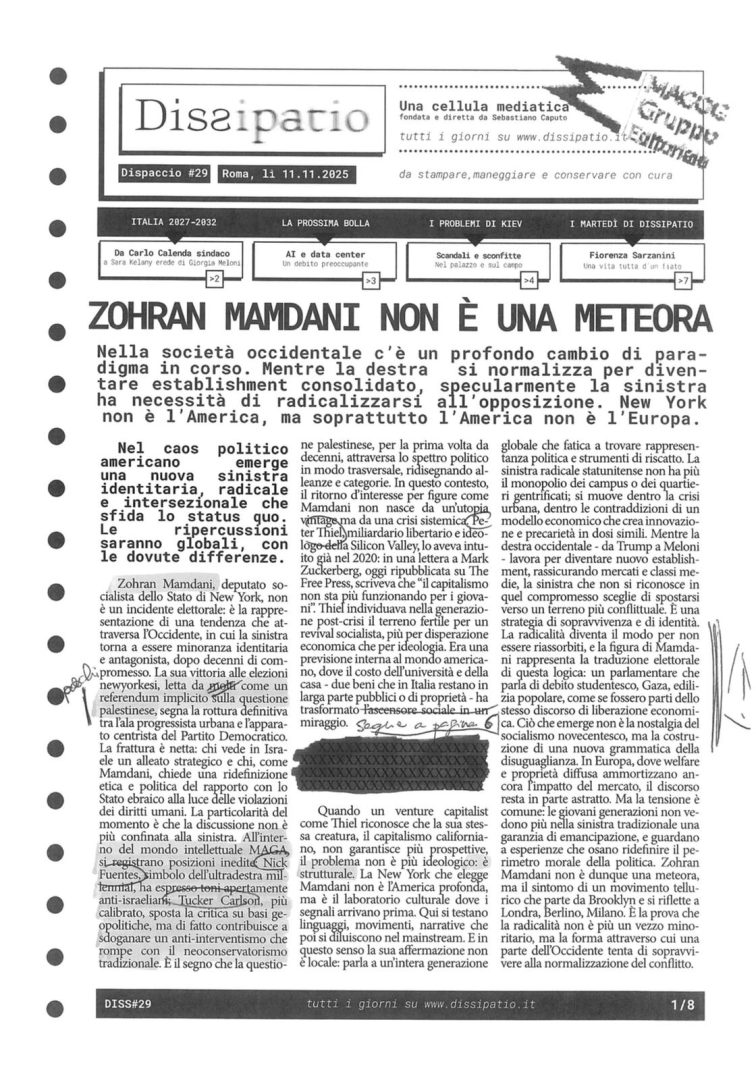La storia di Israele, malgrado la gioventù istituzionale dell’attuale Stato ebraico, è sempre stata incredibilmente ricca di eventi e spunti politici di approfondimento. Quanto sta accadendo a Gaza, nel contesto degli avvenimenti generati dall’attacco palestinese del 7 ottobre 2023, non fa eccezione. Non c’è dubbio che l’evoluzione in corso abbia condotto Israele a diverse possibili exit strategies, contemplanti il cessate il fuoco, l’accordo per la liberazione degli ostaggi in vita ancora detenuti e sapientemente centellinati dalla regia di Hamas, l’occupazione della Striscia. Dopo aver infranto il cessate il fuoco in marzo, e dopo due mesi di tregua, Israele ha ripreso le operazioni belliche su larga scala, tanto da approvare in maggio l’operazione Carri di Gedeone, simbolicamente destinata a rammentare il messaggio che Tel Aviv sta combattendo per difendersi da una minaccia esistenziale per cui deve necessariamente combattere per la graduale conquista dell’intera Striscia; un’operazione che ha previsto sia la mobilitazione di migliaia di riservisti, sia lo sfollamento forzato della popolazione palestinese verso aree già poste sotto il controllo militare israeliano. Nonostante Israele abbia inflitto ad Hamas gravi perdite, gli obiettivi non sono ancora stati completamente raggiunti; Hamas continua ad operare quale potere dominante in parti sostanziali e simbolicamente rilevanti della Striscia; controlla di fatto l’area di Gaza City, la parte occidentale di Khan Yunis, i campi profughi centrali, l’area di al-Mawasi, densamente popolata, senza contare che controlla la maggior parte degli aiuti umanitari che entrano nel nord di Gaza.
Militarmente, l’organizzazione si è conformata alla realtà contingente, recuperando sia pur parzialmente le sue capacità e rinfoltendo i ranghi con giovani reclute per poter continuare a perseguire la ragion d’essere prevalente, la distruzione di Israele. Nel nord di Gaza, Hamas ha rafforzato la sua autorità giustiziando i sospetti collaboratori di Israele, gestendo l’economia. In alcune aree meridionali il suo potere si è fiaccato per la perdita di controllo sulla distribuzione degli aiuti e della crescente attività delle milizie di Abu Shabab, che ha ricevuto dall’IDF il controllo su gran parte dell’area tra Khan Yunis e Rafah. Tel Aviv deve ancora concretizzare fattivamente le condizioni necessarie al rilascio di tutti gli ostaggi, posto che Hamas detiene ancora 20 ostaggi vivi e i resti di altri 30, e che è del tutto possibile che i palestinesi possano incontrare serie difficoltà ad accedere ai corpi di alcuni dei deceduti sia perché sono stati gestiti da altri gruppi, sia perché le distruzioni hanno alterato il paesaggio sì da rendere impossibile la localizzazione delle sepolture.
La nuova prospettiva di Tel Aviv trascende dunque l’aspetto del mero controllo territoriale per giungere a contemplare l’annessione di intere porzioni di territorio; se l’occupazione trovasse effettivo e totale compimento, Tsahal si troverebbe a combattere in aree finora relativamente risparmiate e dove si è rifugiata la maggior parte degli abitanti. Secondo Times of Israel, le IDF non dispongono, sul campo, di truppe e mezzi sufficienti per un’occupazione totale, cosa che costringerebbe lo Stato ebraico ad un’altra sofferta mobilitazione su larga scala, che porterebbe ad oltrepassare di gran lunga le forze attualmente dispiegate. Utile rammentare come un tipo di operazione di questa portata metterebbe inevitabilmente in pericolo gli ostaggi ancora sequestrati; è questo uno, ma non l’unico, degli elementi che hanno indotto i responsabili militari e dell’intelligence a propendere per un cessate il fuoco funzionale alla liberazione di tutti i sequestrati. Anche il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Eyal Zamir, pur in genere incline ad approcci più convinti, si è persuaso della necessità di addivenire ad un accordo diplomatico, con alle spalle più del 70% della popolazione israeliana tendente a porre un termine alla guerra, con un accordo atto a consentire la liberazione degli ostaggi. L’esasperazione è palpabile, così come è comprensibile che manchi un obiettivo chiaro e realizzabile che ispiri l’idea di una concreta fattibilità. Va dunque considerato quel che il New York Times afferma, ovvero che l’abbandono dei colloqui di luglio da parte di Netanyahu possa essere stato funzionale a disporre di un leverage che, paventando un’occupazione totale possa favorire il raggiungimento di una soluzione olistica contemplante sia la liberazione degli ostaggi, sia la resa incondizionata di Hamas; una posizione che ha comportato, di fatto, l’interruzione dei colloqui mediati da Qatar, Egitto e USA.
Ma a fronte degli annunci politici di Netanyahu, probabilmente avallati da Washington, Tsahal ha reagito con la remissione dello stato d’emergenza, in vigore dal 7 ottobre 2023, uno status che avrebbe comportato, per i soldati di leva, l’estensione coatta del servizio nella riserva per ulteriori 4 mesi. Si tratta, dunque, di provvedimenti che condurranno ad una riduzione quantitativa delle forze regolari secondo la vision del Generale Zamir, non a caso invitato alle dimissioni dal premier come già avvenuto per il predecessore Halevi, che ha assunto decisioni di fatto storiche e difficili, peraltro anche alla luce dell’ondata di suicidi tra i militari in servizio. Ovviamente, la preoccupazione circa l’entità di una frattura istituzionale così profonda, capace di indebolire Israele esiste, tanto da far temere un collasso interno a favore di Hamas, peraltro stigmatizzato dal leader dell’opposizione, Lapid, che ha auspicato, per il futuro, liaison a porte chiuse. Non sembra esserci dubbio che Netanyahu propenda per una completa presa di potere militare a Gaza, cosa che porterebbe ad un irrevocabile e significativo cambiamento nella politica israeliana da quando Tel Aviv si è ritirata dalla Striscia nel 2005; un’operazione del genere soddisferebbe i partner di estrema destra della coalizione di governo, da cui di fatto dipende sempre più il destino politico e non solo di Netanyahu, contrari a qualsiasi accordo di cessate il fuoco e di rilascio di ostaggi che non contempli la vittoria totale su Hamas; un atteggiamento che, pur placando le destre, fomenta il crescente sentimento antigovernativo popolare israeliano.
Parallelamente, Hamas continua a plasmare la percezione cognitiva sia a livello internazionale che all’interno della società israeliana con risultati rimarchevoli; dal suo punto di vista la motivazione americana nel cercare di ottenere un successo diplomatico in grado di porre fine alla guerra garantendo il rilascio degli ostaggi, è considerata come una leva su Tel Aviv per costringere alla flessibilità ed all’accettazione di concessioni negoziali. Il sumud, la fermezza, assume per i palestinesi un valore che trascende qualsiasi significato, ed il semplice fatto di riuscire a sopravvivere come forza armata gazawi, anche in uno stato indebolito, costituisce una vittoria. Del resto, secondo Hamas il 7 ottobre ha fatto progredire l’obiettivo di distruggere Israele riportando la questione palestinese in primo piano ed interrompendo il processo di normalizzazione tra Israele e gli Stati arabi. È evidente che il raggiungimento di questi obiettivi incoraggerà la persistenza dell’asse della resistenza iraniano. L’apparente intento di Hamas di cedere qualsiasi controllo all’ANP è dunque fuorviante finché rimangono operative le sue capacità militari, come sta avvenendo per le due Brigate Gaza e Khan Yunis. Quanto dichiarato dai leader palestinesi fa chiaramente intendere che l’attacco del 7 ottobre, era scientemente considerato come ineludibile preludio all’ampiamente attesa e violenta risposta israeliana, nella presunzione che Tsahal avrebbe evitato di assumere il controllo della Striscia, un’assunzione che, giustificata anche dal rischio rappresentato per gli ostaggi, ha costituito una sorta di polizza assicurativa.
Le decisioni assunte dal gabinetto Netanyahu, dai costi finanziari e militari forse sopravvalutati, di fatto probabilmente inferiori alle ipotizzate 4-6 divisioni delle IDF ma certo non al di sotto di 2-3 e inferiori ai 40 miliardi di NIS, comunque richiederanno un investimento continuativo, laddove un takeover completo danneggerebbe definitivamente l’immagine israeliana, a meno che non si accompagni ad un sostegno regionale arabo e statunitense. La polarizzazione politica interna acuirà le frammentazioni e l’incertezza verso qualsiasi transizione, laddove Israele rimarrebbe comunque responsabile nell’opera di prevenzione di inevitabili revanscismi terroristici. Dal suo punto di vista Israele dovrebbe quindi intensificare la pressione su Hamas anche tramite il Qatar, secondo un disegno strategico calcolato e non come una reazione alle mutevoli circostanze.
E sono proprio le mutevoli circostanze a portare alla ribalta il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Eyal Zamir, convinto che una simile operazione comporterebbe un rischio letale per gli ostaggi, un pericolo operativo inaccettabile, nel momento in cui si intende invece ridurre il carico gravante sulle forze combattenti. L’Esercito è stato chiaro: le carenze nel nuovo modello operativo, ed il ritardo nelle dimissioni, hanno provocato danni rilevanti alla struttura delle riserve, tanto da determinare squilibri nei team combattenti tanto da intaccare anche il sistema di alimentazione delle forze di riserva. Lo scontro militari – esecutivo, non inedito in Israele, trova riflessi anche nel gabinetto di sicurezza, dove si contrappongono due fronti, i falchi delle destre, Itamar ben Gvir e Bezalel Smotrich, ed i rappresentanti militari e degli apparati di sicurezza e intelligence, come il capo del Mossad Barnea, il responsabile della sicurezza nazionale Hanegbi, il generale Nitzan Alon, responsabile del dossier ostaggi ed il ministro degli Esteri Sa’ar, favorevoli ad un nuovo cessate il fuoco.
In questo contesto si dipanano le conseguenze del riconoscimento internazionale di uno Stato palestinese, comunque condizionato dalle iniziative politiche israeliane. Se il governo israeliano dovesse scegliere la rappresaglia, come occupare la Striscia, non sarebbe possibile escludere l’ulteriore isolamento internazionale, il congelamento degli Accordi di Abramo, l’imposizione di sanzioni, l’obbligo di provvedere ad un’area insorgente e devastata. Di fatto, l’unica strada percorribile sembra esser quella di un immediato ritorno al tavolo dei negoziati, rimodulando il potere di veto attribuito ai due attori principali, benché i reciproci riconoscimenti necessari allo svolgimento di trattative risultino particolarmente ardui, malgrado le buone intenzioni franco-saudite. Non è certo che Hamas, con il suo attacco, intendesse consolidare l’idea dei due stati, ma potrebbe tuttavia trarre vantaggio dal riconoscimento internazionale alla stregua di una conquista politica per forgiare una narrativa atta ad assecondare il convincimento che solo la resistenza violenta possa produrre produce risultati validi e funzionali. Dall’altro lato, la mancanza di cooperazione e le misure unilaterali israeliane fiaccheranno i tentativi internazionali di disarmare Hamas rafforzando la sua rilevanza politica.
Piace a questo punto riprendere i pensieri sparsi eppur profondi di analisti davvero meritevoli che hanno pazienza e bontà di spiegare e condividere: in cosa può consistere davvero una vittoria israeliana che non può a questo punto essere limitata a Gaza? Intanto nel riconoscimento della sconfitta da parte del nemico, ma soprattutto nella consapevolezza di una pace non fondata su un affetto ecumenico, ma sul timore incusso, perché in Medio Oriente, se si esce perdenti, si perde anche la terra.