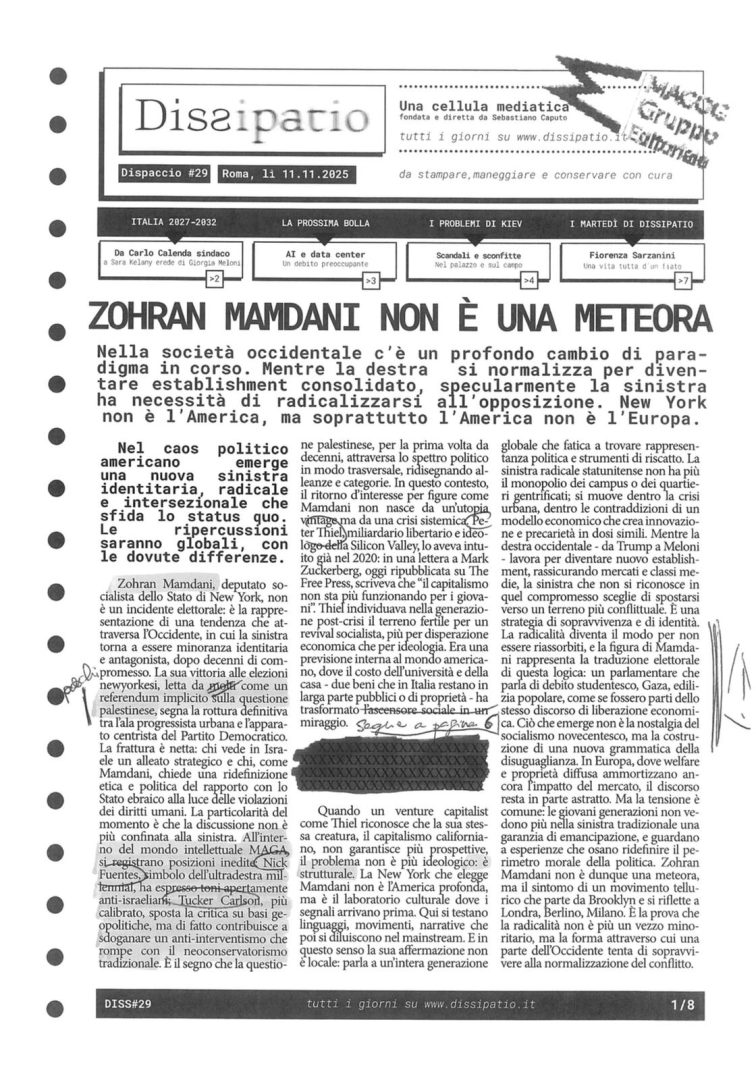Il 15 agosto 2025, l’Alaska – terra venduta dalla Russia agli Stati Uniti nel 1867 – tornerà al centro della scena geopolitica globale, ospitando un incontro senza precedenti tra Donald Trump e Vladimir Putin. Un evento dal sapore storico e simbolico: ex territorio russo, oggi Stato americano, l’Alaska diventa il nuovo teatro neutro per ridisegnare le relazioni tra Mosca e Washington. Non è solo una scelta logistica – metà strada tra Mosca e Washington – ma un messaggio esplicito: si parla di equilibri, di restituzioni, di sovranità. Come ricordato da analisti della Chatham House, Putin potrebbe usare la metafora dell’Alaska per legittimare le proprie pretese sull’Ucraina: “Ve l’abbiamo ceduta, ma era nostra; così l’Ucraina deve restituirci ciò che ci appartiene”. Un parallelo cinico ma efficace in termini narrativi.
Trump, da parte sua, ottiene un punto mediatico essenziale: è Putin a venire da lui, sul suo territorio. È il ritorno della diplomazia del potere, con un tycoon che si presenta come l’unico in grado di parlare con chiunque – a condizioni dettate dalla Casa Bianca.
Nella stessa settimana in cui ha annunciato il vertice, Trump aveva minacciato “sanzioni secondarie” ai Paesi che non si allineano con la politica USA sulla Russia. Una mossa che, più che spaventare Mosca, mirava a tenere in riga gli alleati europei e asiatici, convincendoli a riversare denaro nell’economia americana tramite dazi, appalti e partnership industriali. Si tratta, però, di un bluff noto. Le sanzioni secondarie sono di difficile implementazione, ancor più in un mondo multipolare. Tuttavia, Trump le usa come leva contrattuale: un messaggio agli alleati (“o con me o contro di me”) e una garanzia per l’elettorato americano che l’America First è ancora al centro della sua agenda.
Sullo sfondo del summit, l’Ucraina resta il nodo più evidente e più intrattabile. Secondo le indiscrezioni trapelate da entrambe le parti, Putin intende ottenere: il riconoscimento de jure della Crimea come russa; quello de facto (e forse anche de jure) del Donbass e dei territori attualmente sotto controllo russo nel sud dell’Ucraina; uno scambio territoriale con Kiev, barattando alcune aree di confine per ottenere legittimità sugli oblast strategici. Un’ipotesi che l’Ucraina ha già respinto: “non cederemo nulla”, ha dichiarato Zelensky, sempre più isolato diplomaticamente e vicino a un’uscita di scena.
Nel piano russo si immagina un’Ucraina fuori dalla NATO ma dentro l’UE, in modo da garantire a Bruxelles una “vittoria simbolica”, ma svuotata di potere militare reale. L’Ucraina verrebbe “contenuta” tramite zone cuscinetto, limitazioni militari e impegni per la tutela delle minoranze etniche (russa in primis). In cambio, Mosca accetterebbe un ruolo più definito degli Stati Uniti nel sistema di sicurezza eurasiatico. La posta in gioco è chiara: riconoscere i fatti compiuti sul terreno in cambio di una nuova architettura della sicurezza continentale.
Parallelamente, Trump lavora su un altro dossier esplosivo: la pace tra Armenia e Azerbaigian, che potrebbe concretizzarsi con la firma del memorandum per il “Ponte di Trump”, ovvero il corridoio di Zangezur. Questa infrastruttura di appena 42 km nella regione armena di Syunik è molto più di una strada: è la chiave per un mega-corridoio logistico che collega Europa, Medio Oriente e Asia, bypassando la Russia e paralizzando le ambizioni iraniane sul corridoio Nord-Sud. Dietro la firma del memorandum: gli USA garantiranno la sicurezza con una PMC (compagnia militare privata); una società americana gestirà il traffico per 99 anni; l’Azerbaigian otterrà diritti di transito esclusivi; gli USA investiranno oltre 4 miliardi di dollari. Per Yerevan, che teme una nuova destabilizzazione interna, si tratta dell’ultima occasione per rimanere agganciata all’Occidente. Per Baku, è la consacrazione come attore strategico regionale. Per Trump, è un passaggio verso il Nobel per la Pace e un colpo mortale alle ambizioni russo-iraniane nel Caucaso.
In parallelo al vertice e alle manovre diplomatiche, Trump ha scatenato una nuova ondata di dazi contro oltre 90 Paesi. I dazi, che vanno dal 15% al 50%, colpiscono mercati strategici (Brasile, India, Canada) e settori sensibili come tecnologia, semiconduttori e prodotti agricoli. Le cifre sono impressionanti: oltre 152 miliardi di dollari raccolti fino a luglio 2025; una tariffa media del 18% (mai così alta dal 1934); previsione di un aumento del costo della vita per le famiglie USA di oltre 2400 dollari/anno. Eppure, i dazi non sono una misura puramente economica. Sono una clava politica. Trump li usa per premiare o punire governi a seconda della loro fedeltà. Una diplomazia commerciale iper-aggressiva che disegna un sistema a “tributi” neo-mercantilista: chi vuole accesso al mercato USA deve pagare, letteralmente.
Il vertice in Alaska segna un momento di rottura con l’ordine liberale post-Guerra Fredda. Non si tratta solo di un faccia a faccia tra due leader, ma di un confronto tra due modelli: quello americano trumpiano, protezionista, transazionale, selettivo nei suoi impegni multilaterali; quello russo, imperiale, territoriale, con una visione espansiva mascherata da “sicurezza nazionale”. In mezzo, l’Unione Europea, relegata al ruolo di spettatore pagante. Le trattative le fanno altri; i conti li paga Bruxelles. Il vertice non produrrà una pace immediata, né tantomeno duratura. Ma potrebbe sancire un armistizio geopolitico che permetta a entrambe le parti di dichiarare vittoria. E a Trump, di presentarsi come l’unico uomo capace di chiudere le guerre che altri hanno aperto.