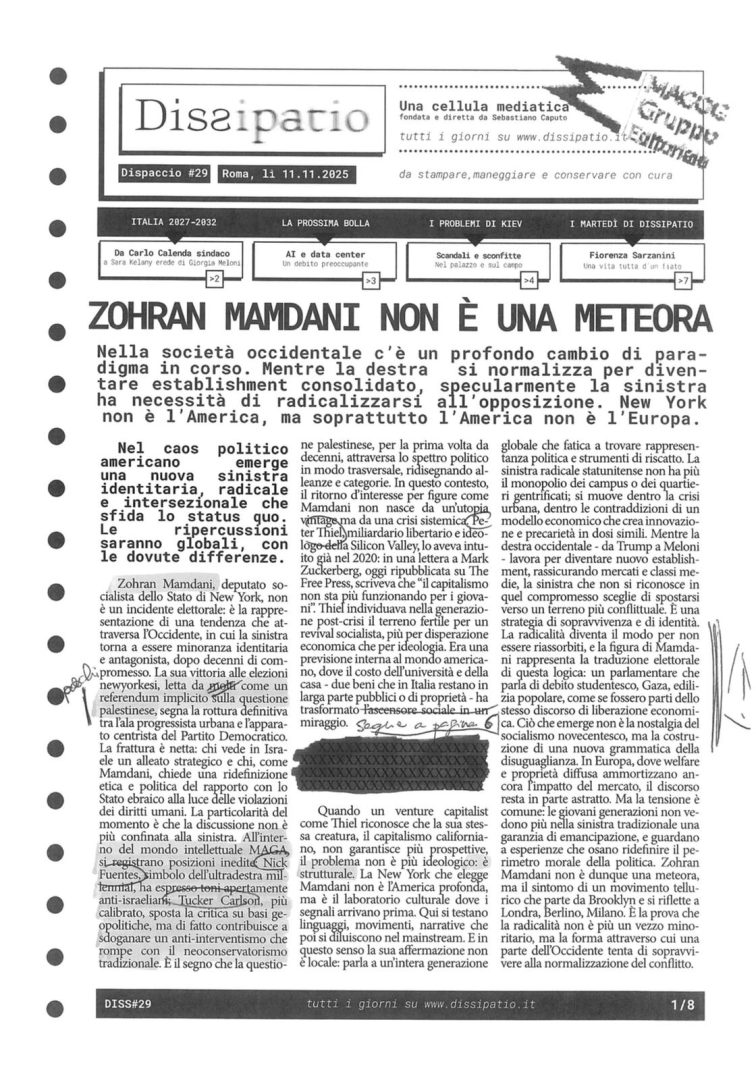Con blocchi stradali, marce simboliche verso Bruxelles e contestazioni elettorali, gli studenti chiedono elezioni anticipate, giustizia e trasparenza. Il caso serbo si pone oggi come un nuovo fronte della geopolitica balcanica, in cui si intrecciano interessi locali e globali, nazionalismo, riformismo e influenze esterne. Un’analisi approfondita delle tensioni in atto e delle prospettive per la Serbia nel suo lungo cammino tra passato e futuro.
In un’epoca in cui i Balcani sembravano relegati a un ruolo marginale nella politica internazionale, la Serbia è tornata prepotentemente al centro del dibattito geopolitico. Da mesi, un’ondata di mobilitazioni studentesche scuote le principali città del Paese, paralizzando infrastrutture e mettendo a dura prova la stabilità dell’attuale governo. Ma ciò che va in scena oggi è molto più di una protesta per la democrazia: è la manifestazione di un conflitto profondo tra due visioni opposte di Serbia — una legata a un passato nazionalista e filorusso, l’altra proiettata verso un futuro europeo e democratico.
La campagna “Kojekude”, che in serbo significa letteralmente “Dove andiamo?”, è il simbolo di una mobilitazione diffusa, radicata nei campus universitari ma capace di coinvolgere interi settori della società. Dai blocchi pacifici a Belgrado ai presidi spontanei a Novi Sad, Cacak, Uzice e Pirot, gli studenti esprimono una rabbia profonda contro un sistema politico percepito come corrotto, repressivo e privo di prospettive.
L’evento catalizzatore fu il crollo di una pensilina della nuova stazione ferroviaria nel 2024 a Novi Sad, che causò la morte di 16 persone. Quel disastro fu attribuito dagli studenti alla corruzione dilagante nei progetti infrastrutturali del governo. Le prime manifestazioni furono simboliche, con mani insanguinate e silenzi collettivi nelle piazze. Poi arrivarono le azioni eclatanti: la biciclettata fino a Strasburgo e la maratona fino a Bruxelles. Un messaggio chiaro: “Vogliamo l’Europa, ma senza questa élite politica”.
Aleksandar Vučić, presidente serbo da oltre un decennio, incarna una leadership forte, ambigua e profondamente radicata in una logica di potere verticale. Pur avendo avviato nel 2014 i negoziati per l’adesione all’Unione Europea, Vučić ha mantenuto saldi rapporti con Mosca e Pechino. Il rifiuto di allinearsi alle sanzioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, l’adesione alla Belt and Road Initiative cinese e il mancato riconoscimento del Kosovo sono solo alcuni degli elementi che rallentano il percorso europeo della Serbia.
Le tensioni etniche e territoriali nei Balcani — dal Kosovo alla Bosnia — continuano ad alimentare un clima instabile, dove ogni piccola scintilla rischia di far esplodere antichi rancori. La recente condanna del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik e la sua alleanza con Vučić e Putin hanno rafforzato il blocco filorusso nella regione. La partecipazione di entrambi alla parata del Giorno della Vittoria a Mosca il 9 maggio è stata un chiaro segnale.
L’8 giugno 2025, nella piccola città di Kosjerić, si è tenuto un voto amministrativo che ha assunto un valore simbolico e strategico. Da una parte, l’intero apparato del potere serbo: infrastrutture rifatte in tempi record, promesse, ministri in visita e campagne mediatiche. Dall’altra, una coalizione di studenti, operai e cittadini, uniti sotto la lista “Uniti per Kosjerić”.
Il risultato è stato sorprendente: il partito di Vučić (SNS) ha vinto con meno di 50 voti di scarto. Un successo effimero, accompagnato da accuse di brogli e richieste di riconteggio. Ma il dato politico è chiaro: per la prima volta, il potere è stato messo seriamente in discussione da un movimento giovanile, civile e organizzato.
Mosca osserva con inquietudine gli sviluppi in Serbia. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avvertito l’Occidente di non “intervenire” e ha evocato lo spettro delle “rivoluzioni colorate” che secondo il Cremlino avrebbero destabilizzato Ucraina e Georgia. Il timore è che Belgrado possa diventare il nuovo fronte di una battaglia per l’influenza in Europa sud-orientale, una regione mai pacificata e strategicamente cruciale.
La Russia continua a garantire forniture energetiche a prezzi agevolati alla Serbia, e non è un caso che, nel pieno delle proteste, il governo di Belgrado abbia ricevuto nuovi contratti da Gazprom. Ma allo stesso tempo, da Bruxelles, giunge un messaggio opposto: la commissaria all’allargamento, Marta Kos, ha incontrato gli studenti e ha lodato il loro impegno democratico, accogliendoli “a braccia aperte verso l’Europa”.
La Serbia è oggi sospesa tra due poli opposti: da un lato, un sistema di potere autoritario, sostenuto da Mosca e da settori nostalgici del nazionalismo balcanico; dall’altro, una nuova generazione che chiede riforme, trasparenza e apertura europea. In mezzo, un’Unione Europea che fatica a proporre un’alternativa credibile e rapida, e una Russia che cerca di consolidare la sua influenza in un’area tradizionalmente alleata.
Il rischio non è solo l’isolamento della Serbia, ma anche la riaccensione di focolai in tutta la regione balcanica, ancora segnata dai conflitti degli anni ‘90. La partita si gioca ora nelle strade di Belgrado e nelle piazze di città dimenticate. La Serbia del 2025 è una nazione in fermento, attraversata da una crisi di legittimità e da un desiderio autentico di trasformazione.
Il movimento studentesco non ha ancora ottenuto una vittoria definitiva, ma ha dimostrato che esiste un’alternativa al potere consolidato. Ha riacceso il dibattito politico, ridato voce a una società civile spesso silenziata e ha reso visibile un’altra Serbia, quella che guarda a Bruxelles non solo come a un’opportunità economica, ma come a una scelta di valori.
Le elezioni del 2027 saranno decisive. Ma già oggi il potere di Vučić vacilla sotto la pressione di una generazione che marcia, pedala e si fa sentire. Una generazione che, forse, può finalmente voltare pagina.