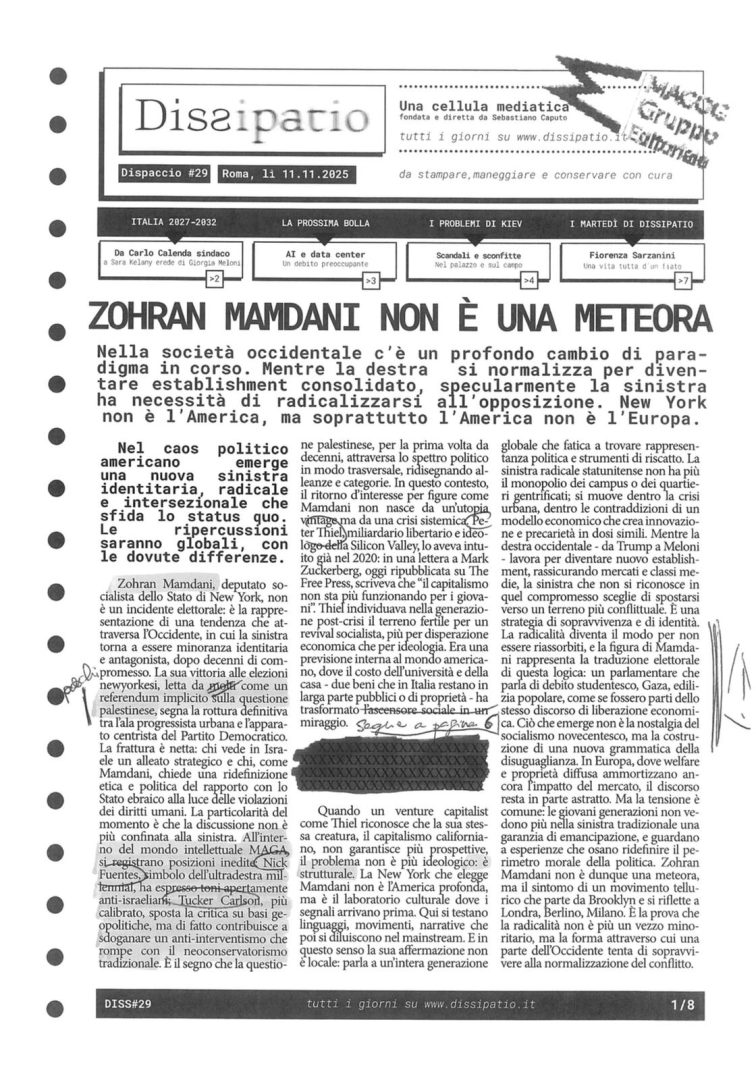Nell’attuale contesto internazionale emergono nuovi equilibri regionali e globali, con Israele, Russia, Cina e Pakistan in grado d’influenzare profondamente il campo da gioco. Il risultato, nel caso del conflitto mediorientale fra Tel Aviv e Teheran, è una tregua fragile, dove la pace non è frutto di intese solide, ma di un equilibrio precario tra interessi divergenti e volontà politiche in cerca di legittimazione interna.
La recente crisi tra Stati Uniti e Iran, culminata nel bombardamento statunitense di un sito nucleare iraniano, rappresenta un caso emblematico di “escalation teatrale”, una dinamica già osservata in precedenti confronti geopolitici, dove il conflitto viene messo in scena più che combattuto, con l’obiettivo di inviare segnali senza oltrepassare il punto di non ritorno. Secondo analisti vicini ai circuiti della sicurezza internazionale, il bombardamento del sito iraniano — da cui erano state rimosse in anticipo le componenti sensibili — non aveva uno scopo militare concreto, bensì una funzione politica: mostrare determinazione verso Teheran, rassicurare l’opinione pubblica americana, rispondere alle pressioni israeliane, e lanciare un segnale a potenze come Russia e Cina.
L’ipotesi, suffragata da fonti diplomatiche, suggerisce che gli Stati Uniti avrebbero preannunciato l’attacco all’Iran attraverso canali riservati — come la Svizzera o il Qatar — con lo scopo di evitare vittime e mantenere l’operazione entro i confini della simbologia strategica. Teheran, consapevole dell’importanza della narrativa interna, ha reagito con un attacco missilistico mirato a una base americana già evacuata, probabilmente Ain al-Asad in Iraq o Al Udeid in Qatar. L’obiettivo era analogo: salvaguardare l’onore nazionale senza provocare vittime statunitensi, evitando così una rappresaglia devastante.
Il modello dell’escalation controllata non è nuovo. Nel 2017 Trump bombardò la Siria avvertendo la Russia in anticipo. Nel 2020, dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, l’Iran colpì la base di Ain al-Asad evitando di causare perdite umane, in seguito a un’avvenuta evacuazione.
Ciò suggerisce che il teatro del conflitto moderno, almeno tra potenze o quasi-potenti, si gioca sempre più sul piano della percezione pubblica e della gestione delle linee rosse, piuttosto che su quello della distruzione fisica.
L’operazione militare americana, secondo fonti vicine all’intelligence, sarebbe stata fortemente sollecitata da Israele, che percepisce il programma nucleare iraniano come una minaccia esistenziale. A spingere per l’azione anche una parte del Congresso (neoconservatori e falchi repubblicani) e segmenti del Pentagono. Trump, inizialmente riluttante, avrebbe ceduto a queste pressioni, pur cercando di limitare l’azione a una dimostrazione di forza calibrata. Con solo il 25% della sua base elettorale favorevole all’intervento, ha tentato di trasformare l’operazione in una triplice dichiarazione di vittoria: verso l’esterno, verso l’interno, e verso Israele.
La risposta iraniana è stata sostenuta da una rete di alleati strategici: la Cina, interessata a difendere la propria via commerciale mediorientale; il Pakistan, con storici legami di cooperazione militare; e la Russia, vero architetto del programma nucleare civile iraniano. Mosca gioca un ruolo chiave. Essendo il principale fornitore e garante del know-how nucleare di Teheran, solo il Cremlino può realmente vincolare l’Iran a un uso civile dell’energia atomica. E proprio qui entra in gioco il dilemma degli Stati Uniti: per stabilizzare l’Iran, serve un accordo con la Russia. Ma tale dialogo, dopo anni di tensioni e rotture unilaterali da parte americana, è tutt’altro che semplice.
In questo scenario emerge la figura di JD Vance, senatore e possibile candidato alla presidenza, che ha compreso il rischio esistenziale di un conflitto su vasta scala. Pur non mosso da simpatia verso il regime iraniano, Vance si oppone a un coinvolgimento totale degli Stati Uniti in un conflitto per procura che vedrebbe Teheran appoggiata da tre potenze nucleari. Per Vance, il territorio iraniano, salvo nei cieli dominati da Israele e USA, resta in mano agli iraniani, e nessuna guerra moderna può essere vinta con il solo controllo aereo. La sua linea mira a preservare l’equilibrio attraverso il disimpegno e la diplomazia silenziosa.
L’Unione Europea, in particolare la Germania di Friedrich Merz, ha adottato una posizione ambigua e ipocrita. Mentre si scaglia contro l’Iran per violazioni dei diritti, Berlino resta il principale partner commerciale di Teheran. A livello internazionale, l’UE viene spesso ridicolizzata per la sua irrilevanza diplomatica nella regione. Il vecchio continente assiste, senza incidere, a una partita globale dove gli equilibri si decidono altrove.
Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti non è il frutto di una pace strutturata, ma di una tregua precaria, costruita su calcoli razionali e comunicazioni informali. La deterrenza reciproca ha funzionato — per ora — ma l’assenza di veri canali negoziali, l’ambizione di Israele, e le alleanze strategiche dell’Iran con Mosca, Pechino e Islamabad, lasciano aperto ogni possibile sviluppo. L’Iran potrebbe uscire dal JCPOA, accusando l’AIEA di connivenza con Israele. Israele, pur dominante nei cieli, non può affrontare Teheran da sola. E gli Stati Uniti, per evitare un nuovo “pantano persiano”, potrebbero trovarsi costretti a negoziare con Mosca — proprio mentre i rapporti russo-americani toccano i minimi storici. La pace, se verrà, non sarà gratuita. E la sua architettura passerà da tavoli di trattativa ancora assenti. Ma una cosa è certa: il nuovo ordine globale non si costruirà con la forza, ma con la capacità di negoziare l’equilibrio in un mondo a geometria variabile.