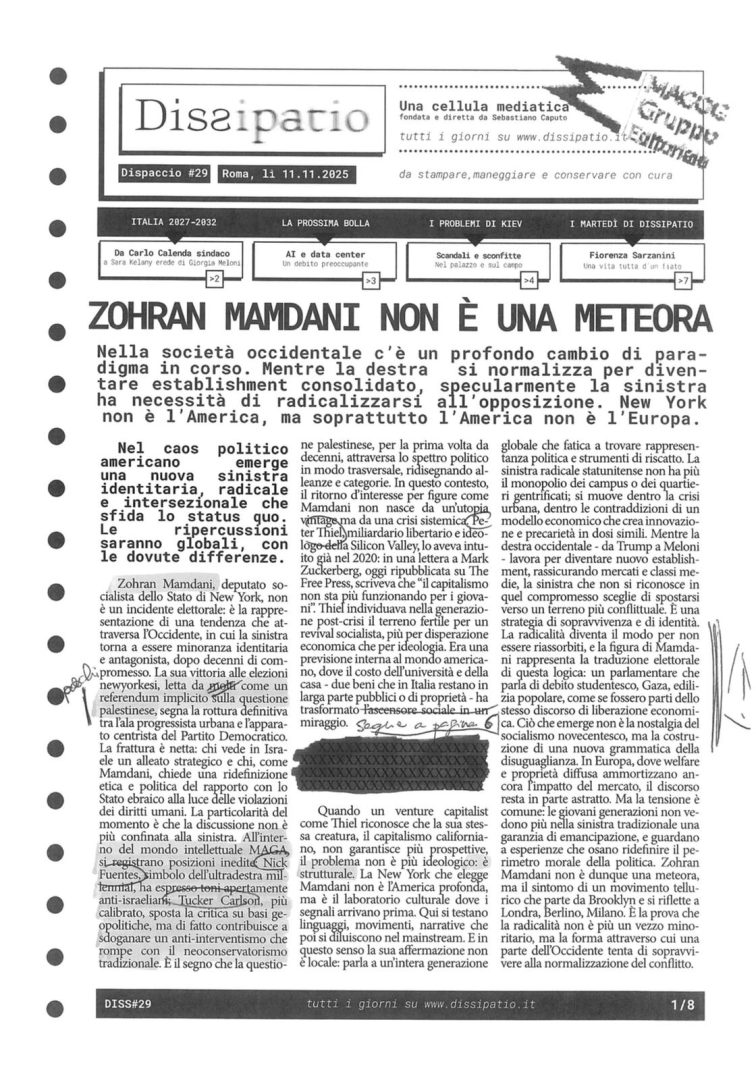La recente condanna di Sarkozy per finanziamenti illeciti provenienti dal regime libico aggiunge una dimensione giudiziaria e morale a un fallimento che ha travolto un’intera generazione politica. Nel marzo del 2011, la Francia diede avvio all’operazione “Harmattan”, coinvolgendo anche il Regno Unito e, più tardi, la NATO, nel bombardamento del regime libico di Muammar Gheddafi. L’intervento fu presentato come una risposta umanitaria alla repressione delle rivolte scoppiate in Cirenaica. Ma dietro la retorica dei diritti umani si celavano calcoli politici, rivalità regionali e ambizioni personali. A differenza delle guerre precedenti nel mondo arabo, fu questa la prima crisi nel Mediterraneo in cui Washington si limitò a seguire, lasciando a Parigi la guida dell’azione militare. Barack Obama, reduce dalle esperienze in Iraq e Afghanistan, era riluttante a intervenire. La leadership venne presa da Sarkozy, supportato dal premier britannico David Cameron e da un Qatar sempre più attivo nel sostenere i Fratelli Musulmani e i ribelli libici. La Risoluzione 1973 dell’ONU, che autorizzava una no-fly zone, fu interpretata come un lasciapassare per un cambio di regime.
L’intervento militare fu un’occasione per Sarkozy di risollevare la sua immagine interna, minata dalle rivolte arabe, dallo scandalo Ben Ali e dalla perdita d’influenza in Tunisia ed Egitto. A ciò si aggiungevano rivalità economiche con l’Italia, fortemente presente in Libia grazie agli accordi energetici tra ENI e Tripoli. L’obiettivo era chiaro: ridisegnare gli equilibri nel Mediterraneo ponendo la Francia al centro, anche a costo di scavalcare alleati storici come Roma e Berlino. Ma la narrativa si è capovolta nel tempo. Nel settembre 2025, Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere per aver ricevuto finanziamenti occulti da parte del regime di Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007. Il contrasto è stridente: l’uomo che ricevette denaro dal Colonnello fu anche colui che ne ordinò la caduta militare, contribuendo al collasso del Paese. Una contraddizione politica che oggi ha assunto anche una rilevanza penale.
Con la caduta del regime, la Libia non è rinata. È implosa. Si è trasformata in un mosaico di milizie armate, città-Stato, governi paralleli e interferenze straniere. Tripolitania e Cirenaica sono oggi territori sotto controllo di attori diversi, sostenuti da potenze esterne: Turchia, Russia, Egitto, Emirati Arabi e Qatar si contendono l’influenza in un Paese che non esiste più come entità sovrana. Gli arsenali di Gheddafi, lasciati incustoditi, hanno alimentato il terrorismo jihadista nel Sahel. Il caos libico ha aperto corridoi migratori che mettono quotidianamente sotto pressione l’Europa, e soprattutto l’Italia. Il fallimento del progetto di “democratizzazione” si è riflesso anche nel Mediterraneo allargato, dove la credibilità occidentale è ai minimi storici.
L’intervento del 2011 ha mostrato l’incapacità dell’Europa di agire come soggetto geopolitico coeso. La Francia ha agito per conto proprio, l’Italia è stata marginalizzata, la Germania si è smarcata, la NATO si è adattata a una guerra non voluta, e gli Stati Uniti hanno delegato senza coinvolgersi realmente. L’illusione che l’Unione per il Mediterraneo potesse essere lo strumento politico per stabilizzare il Sud è stata spazzata via da un’azione militare improvvisata e dalle sue conseguenze.
La figura di Sarkozy incarna perfettamente questa parabola storica. Eletto nel 2007 come simbolo di rottura e modernità, esce oggi dalla scena pubblica segnato da condanne penali, dall’umiliazione giudiziaria e dalla perdita della sua influenza politica. La sua condanna non è solo il crollo di un uomo, ma il simbolo del fallimento di un’intera stagione politica: quella in cui si pensava che l’Europa potesse guidare il Mediterraneo senza una visione condivisa e senza un piano per il “giorno dopo”.
A distanza di oltre un decennio, la guerra in Libia ci consegna una lezione dura: distruggere una dittatura non significa costruire una democrazia. Sottovalutare le complessità regionali, forzare i processi politici con le armi e illudersi che il prestigio internazionale possa essere conquistato con una guerra-lampo sono errori che il Mediterraneo sta ancora pagando. La giustizia francese ha chiuso il caso Sarkozy. Ma la ferita geopolitica è ancora aperta. E a pagarne il prezzo più alto non sono solo i protagonisti della politica europea, ma le popolazioni del Nord Africa, del Sahel e delle coste europee. Finché quella ferita non sarà sanata con una strategia condivisa, visione a lungo termine e rispetto del diritto internazionale, il Mediterraneo resterà ciò che è oggi: un mare in guerra, senza pace, né futuro.