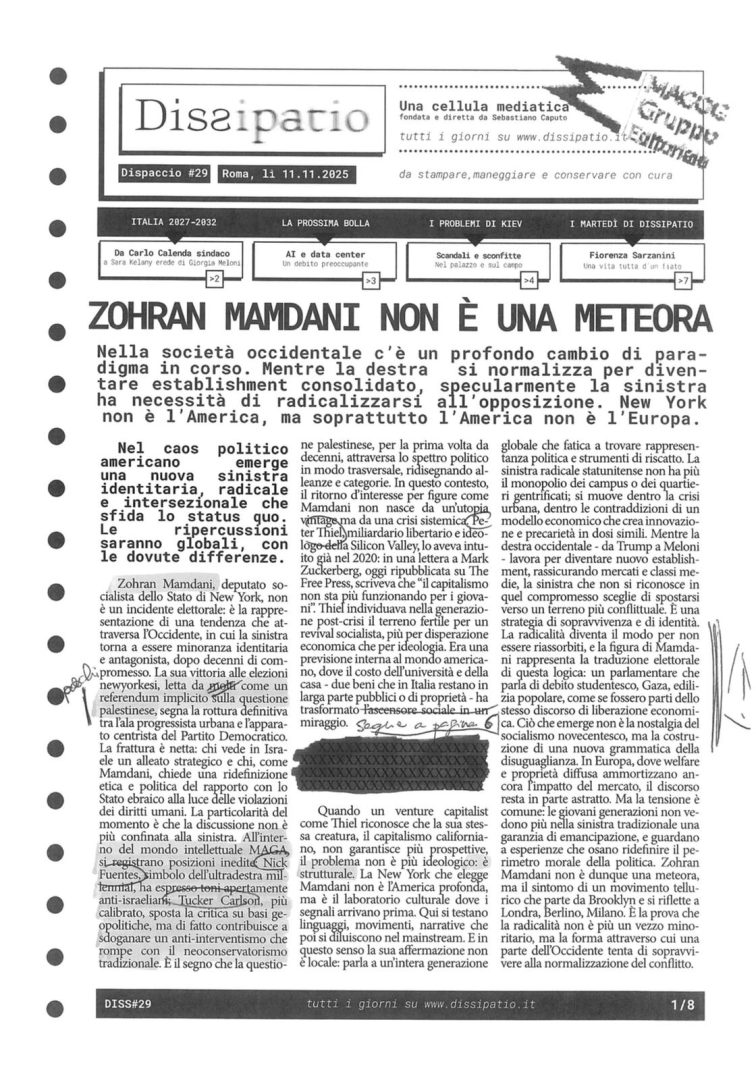Il 22 settembre 1979, un satellite statunitense della classe Vela Hotel — così chiamato per la sua forma caratteristica — registrò un’esplosione multipla nell’Oceano Indiano, nei pressi delle remote Isole del Principe Edoardo, al largo del Sudafrica. Progettati appositamente per rilevare eventuali test nucleari grazie al caratteristico “doppio lampo” delle detonazioni atomiche, i satelliti Vela costituivano l’occhio vigile di Washington sul rispetto dei trattati internazionali di non proliferazione.
Il segnale ottico fu inequivocabile, ma mancavano prove collaterali: non furono rilevate onde sismiche o acustiche. L’unico indizio concreto arrivò settimane dopo, quando tracce di iodio-131 — un prodotto tipico della fissione nucleare — furono trovate nelle tiroidi di greggi ovini nell’Australia orientale, probabilmente trasportate dai venti oceanici. Ulteriori riscontri giunsero anche dal radiotelescopio di Arecibo, a Porto Rico, che rilevò un’anomalia nella ionosfera.
Gli esperti del laboratorio nazionale di Los Alamos, che avevano partecipato al programma Vela, si dissero certi della veridicità del segnale. Lo strumento, operativo da oltre dieci anni, era stato ricalibrato appena due mesi prima da figure di primissimo piano: Harold M. Agnew, direttore del laboratorio; Richard L. Garwin, progettista della prima bomba H e scienziato di punta dell’IBM Watson Laboratory; e Stephen Lukasik, capo scienziato della Federal Communication Commission ed ex responsabile della Rand Corporation.
Il loro rapporto dell’ottobre 1979, reso pubblico solo anni dopo nei documenti di Gerard C. Smith (rappresentante speciale di Jimmy Carter per la non proliferazione), concludeva senza mezzi termini che “i segnali erano coerenti con il rilevamento di una detonazione atomica nell’atmosfera”.
Per approfondire, Washington inviò nella zona una missione con 25 aerei della US Air Force, che però non individuò ricadute radioattive. Priva della “pistola fumante”, l’amministrazione Carter preferì attribuire l’evento a un fenomeno atmosferico anomalo, come la caduta di un meteorite.
All’epoca solo due Paesi erano sospettati di condurre programmi nucleari segreti: Israele e Sudafrica. La localizzazione geografica del segnale fece ricadere i sospetti su Pretoria. Dal 1977, infatti, il Sudafrica era sottoposto a un embargo internazionale in risposta alla politica di apartheid, che includeva la cancellazione delle forniture statunitensi di uranio arricchito, necessario al reattoresudafricano Safari. Nel frattempo, il paese era impegnato in Angola in una logorante guerra contro i movimenti indipendentisti sostenuti da Cuba e URSS.
Pertanto, privo di alleati sia in Occidente che nel blocco comunista, Pretoria intensificò la cooperazione con Israele, che già intratteneva rapporti stretti in materia di armamenti e materie prime. In particolare, il Sudafrica forniva a Tel Aviv ingenti quantità di uranio “yellowcake”, indispensabile per il programma nucleare israeliano.
Telegrammi del Dipartimento di Stato, inseriti nel fascicolo Smith, confermano che nel febbraio 1980 Jack Ruina, fisico del MIT e membro del panel scientifico voluto da Carter, ricevette informazioni dirette da Anselm Yaron, esperto missilistico israeliano in visita accademica a Boston. Yaron descrisse le capacità nucleari israeliane e il suo coinvolgimento nello sviluppo missilistico. Ruina trasmise il tutto a Spurgeon Keeny, vicedirettore dell’Arms Control and Disarmament Agency, che però accolse la notizia con scetticismo.
Secondo diverse ipotesi, il test del 22 settembre sarebbe stato condotto con un ordigno tattico di piccole dimensioni, lanciato da una piattaforma navale, capace di produrre un fallout minimo e dunque difficile da rintracciare. In cambio della logistica e del territorio, Israele avrebbe fornito supporto tecnico al programma atomico del Sudafrica, replicando il modello di cooperazione che negli anni ’50 aveva legato Tel Aviv alla Francia.
Dopo la fine dell’apartheid, l’apertura parziale degli archivi sudafricani confermò che Pretoria disponeva della tecnologia per realizzare un’arma simile a partire dal novembre 1979, proprio due mesi dopo il presunto test. Un dettaglio che sembrava rafforzare i sospetti su Israele.
Il 21 febbraio 1980 la CBS Evening News trasmise un servizio del corrispondente da Tel Aviv, Dan Raviv, che sosteneva che l’evento Vela fosse stato un test israeliano. Raviv citava un manoscritto inedito dei giornalisti Eli Teicher e Ami Dor-On, None Will Survive Us: The Story of the Israel Atomic Bomb, censurato in Israele, e aveva inoltre raccolto la testimonianza del politico EliyahuSpeiser, membro della Knesset dal 1977 al 1988, che confermò l’esistenza del test.
Lo scoop ebbe conseguenze pesanti: Raviv perse le credenziali giornalistiche e fu espulso da Israele su ordine del ministro della Difesa Ezer Weizman.
In quel periodo, Jimmy Carter affrontava crisi decisive: la rivoluzione iraniana e la crisi degli ostaggi a Teheran, i negoziati con Mosca sul controllo degli armamenti e la campagna per la rielezione. Ammettere un test nucleare israeliano avrebbe significato imporre sanzioni immediate a Tel Aviv in base ai trattati TNP e Partial Test Ban Treaty, e soprattutto rivelare l’esistenza dell’arsenale atomico israeliano, negata tuttoggi, con il rischio di alimentare la proliferazione nucleare globale.
Una rivelazione simile avrebbe anche reso evidente il doppio standard americano: proprio in quegli anni, l’India aveva effettuato il suo primo test, Smiling Buddha, con la partecipazione indiretta degli Stati Uniti attraverso la fornitura di acqua pesante.
Non sorprende quindi che esponenti di primo piano dell’amministrazione cercassero di minimizzare l’accaduto. Carter stesso era consapevole della realtà, come annotò nel suo diario il 22 settembre 1979: “C’è l’indicazione di un’esplosione nucleare nella regione del Sudafrica, o in Sudafrica. Israele ha usato una nave in mare o niente”.
Conferme indirette giunsero anche da Dieter Gerhart, ex ammiraglio sudafricano arrestato come spia sovietica, che dichiarò: “Ho saputo ufficiosamente che il flash fu prodotto da un test israelo-sudafricano, nome in codice Operation Phoenix. L’esplosione era pulita e non doveva essere rilevata. Ma non furono così intelligenti come pensavano, e gli americani riuscirono a scoprirla”.
Alla fine, l’amministrazione Carter classificò ufficialmente l’incidente come fenomeno atmosferico, coprendo Israele, il principale alleato americano in Medio Oriente. Una decisione che evitò una crisi immediata, ma lasciò in eredità uno dei più grandi misteri della Guerra Fredda.
Oggi, a oltre quarant’anni di distanza, il “flash del Vela” rimane ufficialmente inspiegato. Per storici e analisti, tuttavia, resta l’ipotesi più credibile: il primo e unico test nucleare israeliano, condotto con la complicità del Sudafrica, e insabbiato da Washington per ragioni geopolitiche.