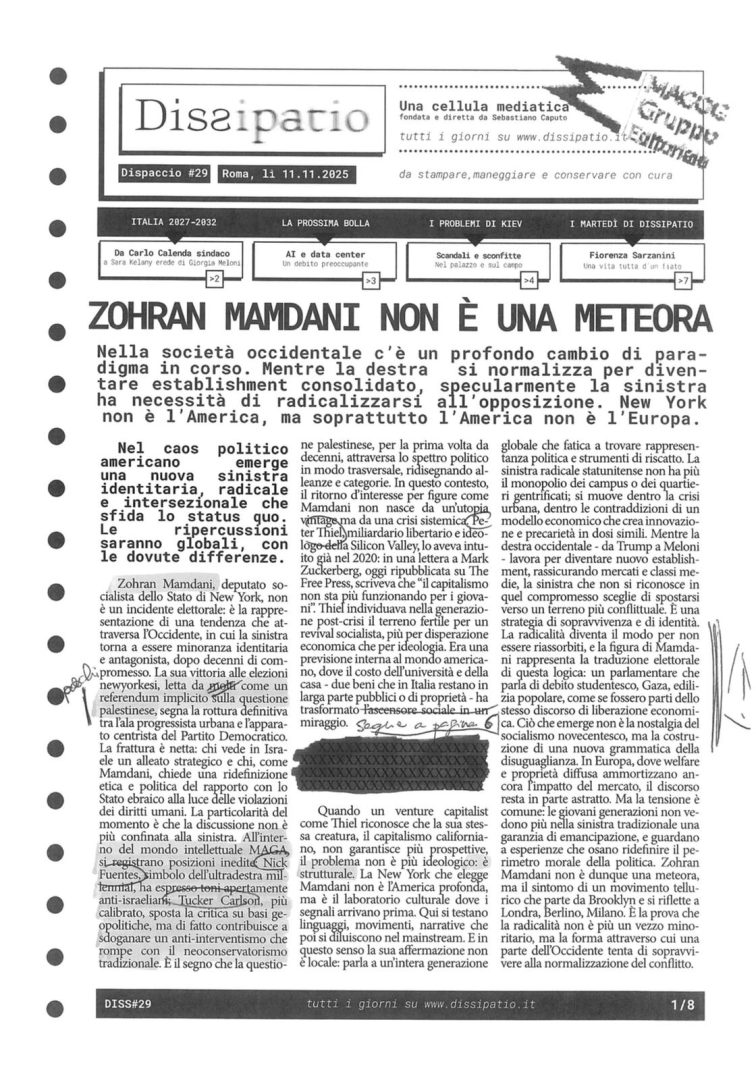Il movimento delle Tute Bianche ha origine a Roma, nel 1998, successivamente alla redazione della Carta di Milano, un documento firmato dai centri sociali del Nord-Est del paese, contenente le richieste politiche principali del movimento. Non una dichiarazione d’intenti a cui aderire o un progetto politico organico, ma una volontà collettiva, nata dell’incontro di diverse realtà autonomiste. Tuttavia, l’apparizione delle Tute Bianche è anteriore alla sua formalizzazione istituzionale. Nel 1993 infatti, un gruppo di manifestanti decise di indossare delle tute bianche durante una protesta sui tetti della sede storica del Leoncavallo, in difesa di Radio Onda Diretta. Successivamente a questa prima apparizione, dal forte valore simbolico, si colloca la manifestazione nazionale dei centri sociale del 10 settembre. 1994. Il corteo fu promosso in risposta allo sgombero della sede del Leoncavallo in Salamone 71, operazione fortemente voluta dal neo-sindaco Marco Formentini, candidatosi con la Lega Nord alla tornata elettorale del 1993.
Il corteo dell’“opposizione sociale”, che radunò a Milano circa 20.000 manifestanti, si volse in un clima di altissima tensione. Fu proprio in questa occasione che le Tute Bianche misero in atto per la prima volta la pratica dell’autodifesa collettiva, indossando indumenti con imbottiture, caschi e scudi protettivi. Le innovative tecniche di “resistenza attiva” adottate dai manifestanti colsero impreparate le forze dell’ordine, non più in grado di arrestare l’avanzata del corteo. Si trattò di una forma d’azione volta a spezzare un binomio fino a quel momento considerato inseparabile, quello tra violenza e non violenza. Le Tute Bianche vollero rompere la polarità dell’apparato mediatico e soprattutto politico del paese, con il fine di guadagnare frammenti di libertà. Una telecamera riprese gli scontri, e un cronista, incredulo, pronunciò in diretta televisiva una frase diventata poi celebre “La polizia sta retrocedendo”. La protesta terminò presso la nuova sede del Leoncavallo, in via Watteau, occupata dai manifestanti. Dopo diverse ore d’assedio dell’intero quartiere Greco di Milano, le forze dell’ordine furono costrette a ritirarsi, alzando di fatto bandiera bianca.
La scelta di indossare tute bianche rispondeva a una precisa esigenza simbolica: superare l’operaismo, corrente di pensiero che trova nell’operaio massa – solitamente vestito e rappresentato in tuta blu – la figura centrale del conflitto sociale. All’interno del lungo dibattito sul passaggio dal fordismo al post-fordismo, avviato nel quinquennio di lotte sociali ’68-’73 e sviluppatosi pienamente nel corso dell’ultimo decennio del XX secolo, l’operaio dequalificato cessa di essere l’unifica figura di riferimento a livello produttivo e conflittuale. Emergono così nuove soggettività produttive, caratterizzate da una forza lavoro spesso precaria e legata a forme contrattuali atipiche. In questo contesto la scelta del colore bianco assume così un forte valore comunicativo, volto a produrre una suggestione mediatica che si pone l’obiettivo di evidenziare la condizione di una pluralità di soggetti sociali che rifiuta l’invisibilità, reclamando spazio e riconoscimento da parte delle istituzioni.
Tra le principali fonti di ispirazione di questa innovativa forma di comunicazione politica vi fu la profonda influenza del movimento zapatista, nato nel 1994 nello stato messicano del Chiapas. Le azioni di disobbedienza civile dell’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guidato dal Subcomandante Marcos, spinsero le Tute Bianche a rifiutare la violenza gratuita, in favore di azioni organizzate e mediaticamente efficaci. Inoltre, elemento centrale nell’estetica zapatista, e successivamente adottato anche delle Tute Bianche, fu il passamontagna. Uno strumento dal fortissimo valore simbolico, indossato non per celare la l’identità, ma per rendere visibile l’invisibilità della comunità in lotta. Proprio il Subcomandante Marcos era solito ripetere “Dietro il nostro passamontagna siamo tutti uguali”.
Sul finire del millennio, le Tute Bianche diedero impulso a una fase di espansione internazionale del movimento, partecipando attivamente alla formazione del nascente movimento no-global. Il primo grande momento di svolta fu la protesta di Seattle del 30 novembre 1999, in opposizione al vertice dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Per la prima volta, migliaia di attivisti provenienti da tutto il mondo bloccarono i lavori del summit, attraverso forme di disobbedienza collettiva organizzata su scala globale. L’eco di Seattle avrebbe successivamente ispirato anche le piazze europee. Nel settembre del 2000, a Praga, in occasione del vertice del Fondo Monetario Internazionale, il movimento no-global fu nuovamente protagonista, con azioni coordinate, trovando così conferma di una crescente capacità di mobilitazione. Questi episodi rappresentarono una vera e propria prova generale al vertice del G8 di Genova, contribuendo a un’elaborazione sempre più efficace di linguaggi, pratiche e tecniche di difesa collettiva, predisposti alla costruzione di una narrazione condivisa della disobbedienza come forma legittima di conflitto globale.
Durante le giornate del G8 di Genova, le Tute Bianche decisero di non indossare la consueta tenuta, che per anni aveva reso inconfondibili i membri del movimento. Rinunciare a un’identità visiva di gruppo significava confondersi nella pluralità dei corpi in lotta, confermando l’esistenza di un fronte ampio ed eterogeneo. Il ruolo che le Tute Bianche ebbero nella formazione di un consenso collettivo diffuso fu centrale, contribuendo alla mobilitazione di oltre 300.000 persone presso il capoluogo ligure. L’esperienza di Genova rappresentò l’apice dell’attività politica e sociale del collettivo, capace di sperimentare forme di disobbedienza sociale che andarono oltre agli scontri in piazza. Si trattò certamente di uno sforzo imponente, che tuttavia non riuscì a contenere il repentino innalzamento della violenza negli scontri con le forze dell’ordine, che culminò con la tragica morte di Carlo Giuliani, appena ventitreenne.